La questione romana: affare italiano o internazionale?
Se la questione romana si accompagna al Risorgimento italiano e ne diventa un elemento determinante, sia per il raggiungimento dell’unità nazionale, sia per avere la capitale del nuovo Stato, poi tuttavia essa rimane sul tavolo, anche quando scompare lo Stato Pontificio e sembra che lo Stato italiano ne venga fuori più consolidato e più che mai sicuro di aver affrontato al meglio il problema. Ma questo sussisteva, sia per le continue rimostranze da parte del Vaticano, in ragione del sopruso che era stato perpetrato nei confronti del Papa, sia per la tensione interna alla società italiana con il divieto ai cattolici da parte delle autorità religiose di partecipare alla vita nazionale, sia per i risvolti che se ne avevano a livello internazionale, dove il governo italiano non voleva nessun riconoscimento politico e nessuna partecipazione si rappresentanti del Papa, soprattutto per la paura che lì venisse sollevata la questione romana. Occorreva dunque mettere mano alla questione, che non era affatto risolta neppure con le Leggi delle Guarentigie, mai riconosciute dal Vaticano e tutte interne allo Stato italiano. Queste leggi sembravano riconoscere una certa sovranità diplomatica al papa stesso per l’esercizio della sua autorità religiosa, ma in esse si negava che questa autorità avesse anche risvolti di tipo politico. Così il Papa conservava la sua libertà dentro i palazzi, in cui si sentiva comunque prigioniero e defraudato del suo secolare potere temporale; e conservava pure un riconoscimento diplomatico che permetteva di mantenere ambasciatori dei Paesi che lo riconoscevano e nunzi apostolici con gli stessi Paesi. In questo lungo periodo (una sessantina d’anni) vissuto in una sorta di “limbo diplomatico”, non mancarono comunque i rapporti con altri Stati da parte della Santa Sede, la quale firmò con molti di essi dei Concordati, che erano indubbiamente accordi per le questioni religiose, ma di fatto risultavano patti internazionalmente riconosciuti.
E tuttavia, quando la Santa Sede cercava di presenziare a Conferenze in cui erano in gioco i rapporti fra gli Stati per cercare soluzioni diplomatiche ed evitare contenziosi armati, in assenza di una più stabile organizzazione (come sarà la Società delle Nazioni, prima, e l’ONU, poi), il governo italiano bloccò ogni forma di partecipazione ad esse del Vaticano.
Insomma, la situazione era bloccata e non sembrava che si potesse addivenire ad un accordo, pur sempre tentato, anche per certe forme di irrigidimento su entrambi i fronti. La stessa soluzione trovata nel 1929 risultava spesso precaria e sul punto persino di essere rimessa in discussione … Comunque la soluzione richiedeva un accordo che fosse trovato e sancito fra le due parti, e che godesse dell’avallo internazionale. La prova se ne ebbe in occasione della guerra (1940-45), quando la neutralità e la libertà del territorio vaticano vennero rispettate, pur con le tante incognite circa la tenuta nel tempo di questo rispetto.
Va altresì rilevato che i Patti lateranensi, siglati in un Palazzo riconosciuto come territorio vaticano e ancora oggi tale, erano di fatto due. Con il primo, il Trattato, si prendeva atto della nascita di un nuovo Stato con un suo territorio e una sua organizzazione; con il secondo, il Concordato, si disciplinavano le questioni di comune spettanza allo Stato e alla Chiesa sul territorio italiano e per i cittadini italiani. Se il primo rimase – e rimane – in vigore, anche dopo la trasformazione istituzionale dell’Italia, che da monarchia divenne Repubblica, il secondo fu sottoposto a revisione ed è passibile di questo anche per il futuro.
Il cammino per giungere alla Riconciliazione
Come si è arrivati a questo passo?
Il cammino di questa riconciliazione non è stato facile e ci sono state resistenze da ambo le parti, sia perché il Papa considerava l’occupazione del suo “Patrimonio” come una usurpazione, sia perché lo Stato italiano con le Leggi delle Guarentigie riteneva già sufficientemente garantito l’esercizio del magistero pontificio e della sua sovranità, anche senza un territorio su cui governare. Di fatto nessuno entrò nei Palazzi Vaticani e tuttavia essi erano comunque considerati territorio italiano.
Pio IX (1846-1878) così si esprimeva nella sua enciclica “Respicientes ea” del 1 novembre 1870
È noto inoltre che Noi, adempiendo al Nostro dovere, non solo Ci opponemmo sempre ai replicati consigli e alle domande fatteci, con cui si voleva che Noi, vergognosamente, tradissimo l’ufficio Nostro abbandonando e consegnando i diritti e i domini della Chiesa, o stipulando con gli usurpatori una nefanda conciliazione, ma, di più, Noi, a questi iniqui ardimenti e misfatti perpetrati contro ogni diritto umano e divino, opponemmo solenni proteste davanti a Dio e agli uomini, e dichiarammo incorsi nelle censure ecclesiastiche i loro autori e fautori, e, quando fu necessario, li fulminammo con le stesse censure.
…
Noi ritenemmo che non Ci fosse assolutamente lecito abbandonare un’eredità tanto sacra e tanto antica (ossia il temporale dominio di questa Santa Sede, posseduto non senza un evidente disegno della Divina Provvidenza in così lunga serie di secoli dai Nostri Predecessori) né accettare col silenzio che qualcuno s’impadronisse della principale città del mondo cattolico per poi (una volta sovvertita e distrutta la santissima forma di governo che Gesù Cristo affidò alla sua Chiesa, e che fu strutturata sui sacri canoni emanati dallo Spirito di Dio) introdurvi un codice contrario e ripugnante non solo ai sacri canoni ma agli stessi precetti evangelici; insomma, trasferirvi, come è d’abitudine, un nuovo ordine delle cose che tende palesemente ad uniformare e a confondere la Chiesa Cattolica con tutte le altre sette e superstizioni.
Qui il Papa si riferisce al testo di S. Ambrogio circa la vigna di Naboth e soprattutto alla sua resistenza al potere politico del tempo che voleva impadronirsi di alcune chiese milanesi per affidarle agli Ariani. Il vescovo milanese si oppose decisamente in nome di questa eredità e si rinchiuse in chiesa per evitare alla polizia di entrarvi ……
Infine, obbedendo a quell’avvertimento di San Paolo “Quale comunanza della giustizia coll’iniquità? O quale società fra la luce e le tenebre? Quale patto tra Cristo e Belial?” (2Cor 6,14-15) apertamente e chiaramente manifestiamo e dichiariamo che Noi, memori del Nostro ufficio e del solenne giuramento che Ci lega, non prestiamo, né mai presteremo, l’assenso a qualunque conciliazione, che in qualunque modo distrugga o scemi i diritti Nostri, e quindi di Dio e della Santa Sede; parimenti proclamiamo che, pronti certamente con l’aiuto della Divina grazia nella Nostra grave età a bere sino alla feccia per la Chiesa di Cristo il calice che Egli per primo si degnò di bere per la medesima, mai sarà che Noi aderiamo e Ci pieghiamo alle inique domande che Ci faranno. Infatti, come il Nostro predecessore Pio VII diceva: “Far violenza a questo supremo dominio della Sede Apostolica, separare la sua temporale potestà dalla spirituale, disgiungere, svellere, scindere gli uffizi del Pastore e del Principe, null’altro è che voler distruggere e rovinare l’opera di Dio, nulla fuorché sforzarsi che la Religione abbia un danno grandissimo, nulla fuorché spogliarla d’un efficacissimo aiuto, affinché il suo sommo Rettore, Pastore e Vicario di Dio non possa conferire ai cattolici, sparsi in ogni angolo della terra e di là bisognosi di forza e di aiuto, quei soccorsi che si chiedono dalla spirituale potestà di lui, e che nessuno deve impedire” [Alloc. 16 marzo 1808]..
 Anche con il suo successore, Leone XIII (1878-1903) le cose non cambiano: rimane il “Non expedit” per i cattolici in Italia, che impedisce loro la partecipazione alla politica attiva e quindi ai ruoli decisionali di governo nazionale, non invece a quello locale. Ma soprattutto in seguito alla Enciclica sociale più famosa, la Rerum Novarum del 1891, si aprono nuove prospettive di carattere sociale, che vengono quanto mai auspicate per una presenza più capillare e più incisiva nelle realtà locali, mentre rimane l’opposizione ad ogni forma di partito dei cattolici.
Anche con il suo successore, Leone XIII (1878-1903) le cose non cambiano: rimane il “Non expedit” per i cattolici in Italia, che impedisce loro la partecipazione alla politica attiva e quindi ai ruoli decisionali di governo nazionale, non invece a quello locale. Ma soprattutto in seguito alla Enciclica sociale più famosa, la Rerum Novarum del 1891, si aprono nuove prospettive di carattere sociale, che vengono quanto mai auspicate per una presenza più capillare e più incisiva nelle realtà locali, mentre rimane l’opposizione ad ogni forma di partito dei cattolici.
Leone XIII infatti, che pur ammirava l’entusiasmo dei giovani per i problemi sociali, ma non voleva sconfessare la trentennale operosità degli intransigenti, il 18 gennaio 1901 interveniva con l’enciclica Graves de communi, la quale proibiva ancora una volta ai cattolici di svolgere azione politica, concedendo loro di impegnarsi solo nel campo sociale. L’enciclica aveva lo scopo di chiarire il concetto di democrazia cristiana e di sedare così le discordie, divenute in proposito sempre più profonde, tra i cattolici italiani; si conservava quella espressione, ma si intendeva che essa indicasse essenzialmente una “azione benefica verso il popolo”. (Penco, p.477).
Gli anni tra i due secoli furono particolarmente vivaci soprattutto per il dibattito e per l’azione dei cattolici dentro la società e dentro il dibattito politico italiano, senza mai trovare comunque la possibilità concreta di giungere ad una conciliazione. Lo stesso Giolitti che raggiunse un’intesa con il cosiddetto “Patto Gentiloni”, per avere il sostegno dei cattolici in politica, non ne voleva sapere di scendere a patti con la Chiesa, anche per la sua formazione fortemente liberale che voleva la Chiesa relegata nelle sacrestie con la sola possibilità di animare opere benefiche nel campo sociale. Solo alla vigilia della guerra si faceva strada l’ipotesi di ottenere l’internazionalizzazione della Legge delle Guarentigie. Ma non si andò molto oltre ….
Anche il pontificato di Benedetto XV (1914-1922) non fu sottratto alle asprezze polemiche legate alla questione romana: la sua neutralità nella guerra appariva come una presa di posizione ostile all’Italia e favorevole alle Potenze degli Imperi centrali; e negli Accordi di Londra per l’entrata dell’Italia in guerra a fianco dell’Intesa, all’articolo 15 si faceva proprio riferimento alla Santa Sede per impedirle di partecipare alla Conferenza di pace, come avvenne …
Patto di Londra (26 aprile 1915)
L’articolo 15 affermava: “La Francia, la Gran Bretagna e la Russia appoggeranno l’opposizione dell’Italia a tutte le proposte tendenti ad introdurre un rappresentante della Santa Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolamento delle questioni sollevate dalla presente guerra“.
Questo articolo provocò un profondo risentimento nel mondo cattolico. Secondo il filosofo Georges Sorel forse gli americani non si sarebbero così facilmente lasciati trascinare ad abbracciare la causa jugoslava, se i numerosi cattolici degli Stati Uniti non fossero stati ostili all’Italia per colpa di questo articolo. La ragione di fondo dietro l’azione del governo italiano e soprattutto del Ministro degli Esteri Sonnino di voler impedire che la Santa Sede superasse l’isolamento politico partecipando a negoziati di pace, era il timore che la diplomazia vaticana potesse risollevare la Questione Romana ponendola come problema internazionale.
Quella a Versailles fu un’assenza senza precedenti, vista la costante presenza della Santa Sede ad incontri di tal genere, incaricati cioè di porre fine a periodi di conflittualità e a definire nuovi assetti delle relazioni internazionali …
È noto che la stretta connessione tra una partecipazione della Santa Sede alla SdN e la Questione romana era emersa già durante i lavori della Conferenza di Versailles, nei famosi colloqui che si tennero a Parigi fra il maggio e il giugno 1919, tra il capo del Governo italiano Vittorio Emanuele Orlando e l’allora segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari Bonaventura Cerretti, allo scopo di formulare proposte concrete per la soluzione della controversia tra la Santa Sede e l’Italia. In proposito, la posizione vaticana chiedeva, quasi come condizione pregiudiziale, la costituzione di un’entità statuale sotto la sovranità della Santa Sede garantita da una presenza di questa nella SdN, una membership che proprio la sovranità territoriale effettivamente esercitata avrebbe reso possibile. (Buonomo, p. 49.50)
Di fatto la Santa Sede, che pur era tenuta lontana dalle assise internazionali di quell’epoca, vedeva comunque accrescere la sua posizione, sia perché aumentavano le relazioni diplomatiche sia perché venivano stipulati nuovi Concordati, in un periodo del resto piuttosto burrascoso. In effetti erano nati in Europa nuovi Stati, e questi assumevano particolari caratterizzazioni con più o meno manifeste tendenze di tipo autoritario, che richiedevano, se non privilegi, comunque più ampi spazi di libertà di movimento per la Chiesa e per i cattolici.
E va pure riconosciuto che nel periodo postbellico la Santa Sede interviene ed è pure richiesta negli interventi per segnalare o per sentirsi coinvolta in alcune questioni e in alcune situazioni, che vanno anche ben oltre gli interessi di parte o dei suoi fedeli.
Il testo citato ricorda alcuni problemi che vedono l’attività diplomatica della Santa Sede e la vedono impegnata a sostenere anche situazioni dove non erano in gioco solo interessi legati al mondo cattolico …
La fame in Russia durante il periodo della guerra civile: la richiesta di Benedetto XV è di intervenire per lenire le sofferenze della popolazione russa.
La situazione delle minoranze e dei rifugiati: il caso dell’Ungheria che si vedeva privata dei suoi territori e di popolazione ungherese che veniva inglobata nella Romania e nella Jugoslavia, rivela una Santa Sede attenta alle questioni che poi esploderanno in seguito.
Le popolazioni dell’Asia Minore: l’azione messa in campo per i numerosi profughi che la guerra greco-turca aveva creato da ambo le parti, fa della Santa Sede un partner privilegiato.
Un’azione che mostra non solo la capacità della Santa Sede di operare sul piano internazionale, bilaterale e multilaterale, prima del 1929, ma come pure in quel momento storico essa fosse attenta alle questioni di rifugiati e profughi, operando in loro favore indipendentemente dall’appartenenza religiosa. (Buonomo, p. 61)
La questione dei Luoghi Santi in Palestina rivelava un interesse della Santa Sede, che faceva presente alla Società delle Nazioni alcune questioni, non solo e non tanto di difesa dei propri privilegi acquisiti, quanto piuttosto come si dovesse agire a livello internazionale, tenuto conto che molti luoghi santi in Terra Santa avevano un carattere particolare, che non si poteva definire sulla base della nazionalità.
La riforma del calendario gregoriano veniva avanzata per motivi di ordine commerciale, in riferimento alla questione della data della Pasqua da rendere fissa e non mobile, come succedeva e succede tuttora. Non se ne venne a capo di nulla. Ma è interessante sapere che la Società delle Nazioni sentiva la necessità di avere il parere della Santa Sede …
Ciò significa che, anche ad aver perso i territori e la sua immagine di Stato fra gli Stati, anche a trovarsi in difficoltà per l’opposizione italiana a dare spazio nel contesto internazionale, con la paura che si potesse sollevare la “ questione romana”, non solo a livello di alcuni Stati, ma anche di organizzazioni al di sopra delle nazioni stesse, la Santa Sede veniva presa in seria considerazione, segno inequivocabile che si conservava per essa una immagine che la metteva sullo stesso piano degli Stati. La cosa poi divenne scontata con il riconoscimento giuridico che emerse dai Trattati lateranensi.
I prodromi dell’evento
Non sono mai mancate le trattative per arrivare alla conciliazione, pur in presenza di discorsi pubblici che alimentavano invece la polemica.
Da parte delle autorità ecclesiastiche si continuava a sottolineare il sopruso commesso dalle autorità italiane e continuava ad essere in vigore la condanna ferma di Pio IX. Veniva pure raccomandato ai vescovi di non avere a che fare con le autorità in certi momenti, come potevano essere le visite del Re o di altri capi di Stato alle autorità italiane.
Da parte dei governi che si sono succeduti, non solo mancava l’autorità per addivenire ad una forma di soluzione; altre volte si manifestavano veri e propri ostacoli ad ogni forma di riconoscimento della Santa Sede come interlocutrice a livello internazionale.
Era evidente che con i governi di stampo liberale non era possibile alcun forma di conciliazione, per quanto se ne parlasse, anche perché, oltre alle componenti massoniche decisamente anticlericali, occorreva superare l’ostacolo delle diverse anime dei partiti di governo.
Anche quando compare Benedetto XV, già nella sua prima enciclica “Ad beatissimi Apostolorum” del 1 novembre 1922 diceva chiaramente
Ed ora, Venerabili Fratelli, al termine di questa lettera, il Nostro cuore torna spontaneo colà, donde volemmo prendere le mosse. È la parola di pace che Ci ritorna sul labbro; per questo con voti fervidi ed insistenti invochiamo di nuovo, per il bene tanto della società che della Chiesa, la fine dell’attuale disastrosissima guerra. Per il bene della società, affinché, ottenuta che sia la pace, progredisca veramente in ogni ramo del progresso; per il bene della Chiesa di Gesù Cristo, affinché, non trattenuta da ulteriori impedimenti, continui fin nelle più remote contrade della terra ad apportare agli uomini conforto e salute. Purtroppo da lungo tempo la Chiesa non gode di quella libertà di cui avrebbe bisogno; e cioè da quando il suo capo, il Sommo Pontefice, incominciò a mancare di quel presidio che, per disposizione della divina Provvidenza, aveva ottenuto nel volgere dei secoli a tutela della sua libertà.
4
La mancanza di tale presidio è venuta a cagionare, cosa d’altronde inevitabile, un non lieve turbamento in mezzo ai cattolici: coloro difatti che si professano figli del Romano Pontefice, tutti, così i vicini come i lontani, hanno diritto d’essere assicurati che il loro Padre comune nell’esercizio dell’apostolico ministero sia veramente libero da ogni umano potere, e libero assolutamente risulti.
Al voto pertanto d’una pronta pace fra le Nazioni, Noi congiungiamo anche il desiderio della cessazione dello stato anormale in cui si trova il Capo della Chiesa, e che nuoce grandemente, per molti aspetti, alla stessa tranquillità dei popoli. Contro un tale stato Noi rinnoviamo le proteste che i Nostri Predecessori, indottivi non già da umani interessi, ma dalla santità del dovere, alzarono più di una volta; e le rinnoviamo per le stesse cause, per tutelare cioè i diritti e la dignità della Sede Apostolica.
Qui non si parla più di usurpazione e, di conseguenza, della condanna verso i governanti italiani. Qui è accorata invece la richiesta di poter contare ancora su una libertà di movimento, che consenta al Papa di essere al di sopra delle parti. Si tenga presente che siamo in un momento particolarmente grave, come quello della guerra in atto, durante la quale la Santa Sede poteva e doveva svolgere la sua missione senza dover risultare assolutamente di parte, come poi verrà accusato lo stesso Papa nei suoi interventi, compreso quello dell’agosto 1917, quando definì la guerra “un’inutile strage”.
Benedetto XV chiede chiaramente che si ponga fine a questo “stato anormale in cui si trova il Capo della Chiesa”: è evidente che si tende la mano affinché la anormalità venga sistemata … Non risulta che ci siano richieste di tornare allo stato precedente con il ripristino del potere temporale e con la restituzione dei territori usurpati. Si esprime invece il desiderio che il Papa possa essere davvero indipendente per svolgere la sua missione soprattutto a favore della pace.
Non sembrava possibile neppure con Mussolini, che era stato in gioventù un acceso anticlericale e che tale era rimasto anche dopo la sua espulsione dal partito socialista. Ciò che lui rappresentava dopo la guerra era l’anima nazionalista, che si faceva strada anche attraverso le forme violente e non faceva mistero del suo modo di concepire e di esercitare il potere. Ma non sono mancate affermazioni sulla questione romana che potevano far sperare in un esito come quello poi raggiunto nel 1929.
In un discorso al parlamento del 21 giugno 1921 si espresse in tal modo: “Affermo che la tradizione latina e imperiale di Roma oggi è rappresentata dal cattolicesimo. Se, come diceva Mommsen … non si resta a Roma senza un’idea universale, io penso e affermo che l’unica idea universale, che oggi esiste a Roma, è quella che s’irradia dal Vaticano. Penso … che se il Vaticano rinuncia definitivamente ai suoi segni temporalistici – e credo che sia già su questa strada – l’Italia profana e laica dovrebbe fornire al Vaticano gli aiuti materiali, le agevolazioni materiali per le scuole, chiese, ospedali o altro, che una potenza sovrana ha a sua disposizione. Perché lo sviluppo del Cattolicesimo, nel mondo … è di un interesse e di un orgoglio anche per noi che siamo italiani”. (Nacci, p. 86-7)
Ovviamente ci vollero gli anni del consolidamento al potere da parte di Mussolini, il cui regime si può dire inizia con il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, dopo la crisi dovuta all’assassinio di Matteotti. Con l’assetto dittatoriale entrano in vigore anche leggi che vogliono estirpare la pluralità dei partiti, ma anche le società segrete di stampo massonico. Così le due parti appaiono più libere nell’intavolare trattative.
Queste “basi” furono poste il 6 agosto del 1926 quando il Papa autorizzò l’avvocato fiduciario del Vaticano Francesco Pacelli, fratello del futuro Pio XII, a conferire con il consigliere di Stato, Domenico Barone, circa la soluzione della Questione romana; colloqui che iniziarono due giorni dopo nella casa di Barone (Nacci, p. 89)
La discussione richiese tempo anche perché nel frattempo sorgevano problemi che rischiavano di far naufragare l’intesa: la dittatura non poteva permettere che la Chiesa avesse campo libero per iniziative di carattere formativo nei confronti della gioventù; non si metteva in discussione il catechismo, ma non si potevano accettare forme di attività diverse, come i gruppi Scout o l’Azione Cattolica, e naturalmente la Chiesa riaffermava in continuazione la sua imprescindibile azione educativa. C’era poi la questione del Concordato, che già la Chiesa andava realizzando con i vari Stati europei e del mondo in quel periodo, e che si voleva abbinare alla soluzione della questione romana.
Due relazioni del consigliere di Stato Domenico Barone del 12 aprile e dell’agosto 1928 fanno luce non solo sulla buona volontà di quell’esemplare funzionario, ma anche sugli argomenti verso cui le due parti erano più sensibili. Le difficoltà non mancavano. In Vaticano, infatti, si era urtati per la presenza di spie fasciste; a Mussolini d’altra parte, continuavano a giungere proteste – anche da parte di D’Annunzio – per i progetti di conciliazione ormai nell’aria. Il consigliere Barone svolse quindi, a questo proposito, un’attività intensissima fino a compromettere la propria salute, mentre Pio XI già nel marzo sembrava disposto a non irrigidirsi per questioni di territorio, pur protestando, il 25 marzo, contro il tentativo di monopolizzare l’educazione della gioventù e contro le persistenti vessazioni ai danni dell’Azione Cattolica. (Penco, p. 527)
 La firma e la ratifica dei Trattati
La firma e la ratifica dei Trattati
Alla firma si arriva l’11 febbraio 1929, anche se poi la ratifica avviene il 7 giugno dello stesso anno. Nel momento stesso in cui la firma avveniva nel Palazzo Apostolico Lateranense, il Papa teneva un discorso in cui affiorano anche i problemi che accompagnano questa decisione …
Dall’allocuzione di Pio XI ai parroci romani e ai predicatori della Quaresima
(11 febbraio 1929)
Ed ora accenniamo a quell’altra circostanza che Ci fa tanto più cara ed opportuna la vostra assistenza e che rende questa adunanza ben altrimenti memorabile e storica che non per le circostanze pur belle e solenni del settimo anniversario dell’incoronazione e dell’anno giubilare. Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, e forse in questo preciso momento, lassù nel Nostro Palazzo del Laterano (stavamo per dire, parlando a parroci, nella Nostra casa parrocchiale) da parte dell’Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato come Nostro Plenipotenziario e da parte del Cavaliere Mussolini come Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d’Italia, si sottoscrivono un Trattato ed un Concordato.
Un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto « hominibus licet », ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evidentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina rappresentanza ond’è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena.
Un Concordato poi, che volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato, per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di Governi settari od ubbidienti e ligi ai nemici della Chiesa, anche quando forse nemici essi medesimi non erano.
Non vi aspetterete ora da Noi i particolari degli accordi oggi firmati: oltre che il tempo, non lo permetterebbero i delicati riguardi protocollari, non potendosi chiamare quegli accordi perfetti e finiti, finché alle firme dei Plenipotenziari, dopo gli alti suffragi e colle formalità d’uso, non seguano le firme, come suol dirsi, sovrane: riguardi che evidentemente ignorano o dimenticano coloro che attendono per domani la Nostra benedizione solenne «Urbi et orbi » dalla loggia esterna della Basilica di San Pietro.
Vogliamo invece solo premunirvi contro alcuni dubbi e alcune critiche che già si sono affacciati e che probabilmente avranno più largo sviluppo a misura che si diffonderà la notizia dell’odierno avvenimento, affinché voi, a vostra volta, abbiate a premunire gli altri. Non conviene che portiate queste cose, come suol dirsi, in pulpito; anzi, non dovete portarvele per non turbare l’ordine prestabilito alla vostra predicazione; ma anche all’infuori di questa, molti verranno a voi, sia per trarre particolare profitto dalla vostra eloquenza, con conferenze e simili, sia per avere anche sull’attuale argomento pareri tanto più autorevoli ed imparziali quanto più illuminati.
Dubbi e critiche, abbiamo detto; e Ci affrettiamo a soggiungere che, per quel che Ci riguarda personalmente, Ci lasciano e lasceranno sempre molto tranquilli, benché, a dir vero, quei dubbi e quelle critiche si riferiscano principalmente, per non dire unicamente, a Noi, perché principalmente, per non dire unicamente e totalmente, Nostra è la responsabilità, grave e formidabile invero, di quanto è avvenuto e potrà avvenire in conseguenza.
Come si avverte da queste parole c’è la coscienza che l’atto è grande e solenne e comunque foriero di critiche e di prese di distanza che si muovono contro la sua persona e le sue scelte. Ne è consapevole (e un po’ amareggiato), ma nel contempo appare quanto mai deciso ad andare fino in fondo per cogliere questa opportunità e mettere fine al contenzioso che non si poteva trascinare oltre con grave pregiudizio per la Chiesa stessa. Le critiche che gli venivano mosse non riguardavano solo il riconoscimento dell’Italia fascista, visto che il Trattato veniva fatto con Mussolini, ma anche per la rinuncia ai possedimenti territoriali che da secoli appartenevano alla Chiesa.
Se con Mussolini fu più facile ottenere la Conciliazione, non per questo il Trattato aveva le garanzie di quel governo, perché il Trattato, di natura internazionale, avveniva con lo Stato Italiano e quindi, propriamente con la persona del Re, di cui Mussolini era solamente il plenipotenziario, come lo era alla firma per il Vaticano il Card. Gasparri e non il Papa stesso. Se poi esso rimane vincolato alla Costituzione repubblicana, ciò significa che davvero questo Trattato è con lo Stato e non con un regime che è pur sempre transeunte. Per quanto riguarda la rinuncia al territorio “usurpato”, ora si riconosceva che era sufficiente al Papa una vera indipendenza, garantita con un minimo di possedimenti che permettessero l’assoluta estraneità allo Stato italiano. Col tempo la cosa si rivelò una autentica liberazione da una zavorra pesante: il Papa era libero, senza avere le incombenze di un governo temporale, che richiede particolari organismi e leggi …
Maggior entusiasmo Pio XI esprime al Corpo diplomatico qualche giorno dopo, riconoscendo che è nato un nuovo soggetto politico destinato a salvaguardare la missione della Chiesa e del magistero petrino, più ancora di quanto non lo si poteva pensare con la forma precedente del Patrimonio di S. Pietro, ereditato dalla storia.
Discorso di Pio XI al Corpo diplomatico (9 marzo 1929)
Ce n’è un’altra che continua dall’11 febbraio a riempire i paesi e il mondo intero. È questo grande, incomparabile (e forse finora mai verificato) plebiscito, non solo d’Italia, ma di tutte le parti del mondo. Non c’è, in questa parola, esagerazione alcuna. Noi stiamo ricevendo lettere e telegrammi non solo da tutte le città e villaggi d’Italia, non solo da tutte le città e da molti villaggi di tutti i paesi di Europa, ma anche dalle due Americhe, dalle Indie, dalla Cina, dal Giappone, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Nord, dal Centro, dal Sud dell’Africa, dall’Alaska, dal Mackenzie, dall’Hudson, come se si trattasse di un avvenimento del luogo.
Fatto veramente impressionante e che Ci autorizza a dire che non solo il popolo, tutto il popolo d’Italia, ma che i popoli del mondo intero sono con Noi: un vero plebiscito non solamente nazionale, ma mondiale. Ecco la garanzia, la più imponente che si possa pensare ed immaginare. In questo vasto e immenso plebiscito non possiamo non cogliere e rilevare alcune voci che Ci hanno profondamente commossi. È anzitutto la voce del piccolo numero dei sopravvissuti, nei vostri vari paesi, tra i valorosi che, nel corso degli anni, in spirito di fede cattolica hanno messo la loro vita a disposizione e a difesa della Santa Sede. Voi direte a questi valorosi che il Santo Padre ha pregato e applica delle Messe per tutti i loro morti, che sono anche i Nostri morti, indimenticabili.
Appare chiaro, a proposito dei Trattati, che si tratta di due documenti molto diversi, a cui poi si deve aggiungere anche la Convenzione finanziaria, con la quale si fissa l’indennizzo alla Santa Sede da parte dell’Italia, che pur aveva garantito con le Guarentigie un compenso annuale, sempre rifiutato da parte del Papa.
Il Trattato fa nascere di fatto un nuovo Stato del tutto sovrano, la cui indipendenza viene garantita a livello internazionale.
Il Concordato ovviamente riguarda i due Stati in riferimento all’esercizio religioso sul territorio italiano. Questo è stato sottoposto a verifica e ad una nuova intesa nel 1984.
L’impressione suscitata da un accordo così importante e così lungamente atteso fu senza dubbio di grande risonanza, in Italia e all’estero, come dimostrò la vasta eco nella stampa nazionale e internazionale. Altrettanto grande fu ovviamente, secondo i diversi punti di vista, la disparità di giudizi, per quanto prevalessero decisamente quelli positivi. A distanza di un sessantennio dall’occupazione italiana di Roma e della definitiva cessazione del potere temporale, i rapporti tra Stato e Chiesa ricevevano una regolamentazione che poteva dirsi soddisfacente. Vi fu, naturalmente, chi volle andare anche oltre l’intenzione della parti contraenti e dello stesso Pio XI: così, si parlò di un avallo senza riserve dato dalla Chiesa al regime fascista. (Penco, p. 529)
La Conciliazione venne disapprovata da quegli antifascisti – in Patria e all’estero – che deprecarono le trattative intercorse tra la Chiesa e un regime totalitario … Ma di fatto, cessata la dittatura, i Patti Lateranensi vennero accolti tali e quali, come trascendenti nettamente le circostanze e le persone che vi avevano avuto parte, nella costituzione stessa del nuovo Stato democratico e repubblicano e ciò con l’appoggio degli stessi partiti di sinistra (Penco, p. 530).
7
Conclusioni
Di fatto noi abbiamo nella lettura storica di questi Patti lo stretto legame fra il Trattato, costitutivo dello Stato Vaticano, e il Concordato che regola invece i rapporti fra Chiesa e Stato in Italia. “Simul stabunt, simul cadent” – si diceva allora. E c’è pure chi supporne che il giorno della morte di Pio XI (10 febbraio 1939), che era vigilia del decimo anniversario dei Patti, ci fosse già un documento pontificio scritto, con cui, prendendo le distanze dal regime fascista, anche per le sue leggi razziali, si volesse far cadere il Trattato. Ovviamente il documento con c’è ed è da verificare che possa essere stato scritto, anche se non entrò mai in vigore con la morte del suo estensore. Penso che l’impugnazione del Concordato non volesse dire che si dichiarava nullo anche il Trattato con il quale nasceva lo Stato della Città del Vaticano. Questo Trattato ha dimostrato la sua forza anche a livello internazionale in occasione della guerra, quando anche nei mesi di occupazione nazista, i territori dello Stato pontificio, per quanto ristretti, non sono stati invasi e sono diventate isole di libertà per quanti trovarono rifugio e scamparono al pericolo di cadere sotto la polizia politica o sotto le SS naziste. Sta di fatto che nella discussione all’Assemblea Costituzionale, i Patti, nel loro insieme, entrarono a far parte della Costituzione stessa, a dimostrazione che essi non venivano considerati come l’espressione di un regime, ma come un vero e proprio trattato fra due Stati, ben oltre la contingenza storica di un governo oggi sottoposto alla damnatio memoriae.
Ma se il Trattato non è mai caduto, il Concordato è stato sottoposto a revisione. Non poteva essere diversamente per lo Stato italiano che si trovava in presenza di accordi costruiti, qui sì, secondo un sistema totalitario. La revisione era ritenuta necessaria per conformarsi alla legge fondamentale dello Stato, che si presenta democratico. Nel momento più delicato della sua storia non si volevano aprire ulteriori ferite e anche il Partito comunista si adeguò ad accettare entrambi i documenti dei Patti. Se poi si addivenne alla revisione, questa fu pure voluta dalla Chiesa che voleva anch’essa rileggere il Concordato sulla base delle suo nuove Costituzioni redatte con il Concilio Vaticano II.
In genere nelle considerazioni di carattere storico che si fanno sui Patti lateranensi si tende a sottolineare che essi mettono la parola fine al contenzioso tra Italia e Vaticano in seguito alla questione romana, come se si trattasse di un problema bilaterale. Certamente è così per il Concordato. Ma per il Trattato esso ha di fatto l’avallo internazionale, perché da allora viene riconosciuto nel concerto delle nazioni, che c’è pure spazio per una realtà politica e giuridica come lo Stato del Vaticano. Ora esso, anche con un porzione minima di territorio, ha in realtà un grande peso nel sistema internazionale e ce l’ha in forza della sua assoluta indipendenza e sovranità. Se questa era di fatto sospesa nel periodo fra il 1870 e il 1929, nonostante le leggi delle Guarentigie che volevano in maniera unilaterale garantire una sovranità di fatto limitata, ora invece essa viene universalmente riconosciuta. Ciò che oggi esiste è ben diverso da ciò che la storia aveva consegnato al Papa nel corso dei secoli, certamente per l’assetto territoriale, ma anche per il tipo di esercizio di potere che poneva il Papa accanto ad altri Stati, con i loro medesimi problemi di natura sociale e strutturale. Oggi il Papa possiede ancora un territorio su cui governa in maniera totalmente autonoma, ma questo tipo di Stato non ha bisogno di quel genere di infrastrutture che sono invece necessarie altrove. Perciò il Vaticano è ben diverso da quello che era prima del 1870; ma la sua autorità e il suo peso è di gran lunga superiore al precedente e la storia recente ha dimostrato che questa indipendenza ha giovato certamente all’esercizio della sua missione, soprattutto senza l’onere di dover svolgere compiti non propriamente suoi e non propriamente necessari a questa sua missione.
BIBLIOGRAFIA
Pontificio Comitato di scienze storiche- I PATTI LATERANENSI in occasione del XC anniversario (1929-2019)- Libreria Editrice Vaticana – 2019 –
Gregorio Penco – STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA (volume II) Jaca Book – 1977

 150 anni fa, il 20 settembre 1870, data storica per noi italiani, i bersaglieri entravano dalla breccia di porta Pia, a Roma, facendo decadere di fatto lo Stato Pontificio, e, con esso, come si pensava, anche il potere temporale. In realtà potremmo dire che quanto territorialmente rimaneva di quello Stato, erede di un ingrandimento perseguito fino al XVI secolo, veniva sì occupato dal Regno d’Italia, ma non per questo si poteva dire che veniva a decadere quella forma di autonomia, che di fatto i Papi nel corso della storia si sono costruiti, anche con il possesso e il governo di un territorio progressivamente ampliato.
150 anni fa, il 20 settembre 1870, data storica per noi italiani, i bersaglieri entravano dalla breccia di porta Pia, a Roma, facendo decadere di fatto lo Stato Pontificio, e, con esso, come si pensava, anche il potere temporale. In realtà potremmo dire che quanto territorialmente rimaneva di quello Stato, erede di un ingrandimento perseguito fino al XVI secolo, veniva sì occupato dal Regno d’Italia, ma non per questo si poteva dire che veniva a decadere quella forma di autonomia, che di fatto i Papi nel corso della storia si sono costruiti, anche con il possesso e il governo di un territorio progressivamente ampliato. 

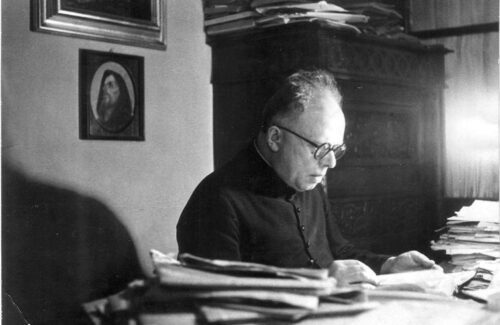
 La nostra immagine di Maria, quella che abbiamo cara perché ci è stata lasciata in consegna da chi ci ha preceduto qui, ci rivela una bella fisionomia di donna, che vuol mostrare e mettere in mano a noi il suo capolavoro. È una giovane mamma che non tiene per sé il suo bimbo, ma lo vuol proporre all’abbraccio nostro, cosicché, prendendolo nella sua tenerezza, abbiamo in mano anche noi colui che il Padre ha mandato come immagine del suo amore e che la Madre ci affida come frutto del suo grembo. Spesso Maria è ritratta nella sua fisionomia femminile piena di grazia, e quindi di una affascinante bellezza, ma anche di quella riservatezza che la fa essere tutta rivolta a Dio: noi abbiamo così l’Immacolata, quando dobbiamo considerare che, ricolma della grazia divina, in lei non appare ombra di peccato; ma abbiamo anche la Donna gloriosa, che salendo a Dio e lasciandosi assorbire dal mondo celeste, risulta sempre più nella luce dell’empireo. Poi si aggiungono altre immagini che colgono un aspetto della sua presenza e della sua azione in favore del popolo cristiano. Fra tutte sono più frequenti le immagini che la mostrano con Gesù an-cora Bambino, fornendo così ciò che maggiormente la qualifica e cioè la sua maternità, quella che noi riconosciamo in modo particolare quando il bambino ha bisogno dell’assistenza della mamma; essa, in genere, tiene in braccio o tiene per mano il suo piccolo, o lo sorveglia con lo sguardo attento e premuroso. Come ogni donna che vive la maternità, anche lei rimane per sempre la madre di Cristo e, per la nostra conformazione a Lui, è pure madre nostra. E così la si può vedere anche in altri momenti della vita di Gesù, come la vediamo spesso affacciarsi a questo mondo, che ella visita spesso con le sue apparizioni. Ma come in queste noi possiamo riconoscerla nel suo privilegiare i piccoli, che sceglie come i suoi interlocutori, non unici, ma certamente più frequenti, così noi la immaginiamo “mamma di Gesù”, soprattutto quando ce l’ha vicino a sé nei momenti della sua infanzia, anche senza pensarla nei giorni iniziali della sua esistenza terrena dentro il rifugio di fortuna trovato a Betlemme. (Per continuare a leggere cliccare QUI
La nostra immagine di Maria, quella che abbiamo cara perché ci è stata lasciata in consegna da chi ci ha preceduto qui, ci rivela una bella fisionomia di donna, che vuol mostrare e mettere in mano a noi il suo capolavoro. È una giovane mamma che non tiene per sé il suo bimbo, ma lo vuol proporre all’abbraccio nostro, cosicché, prendendolo nella sua tenerezza, abbiamo in mano anche noi colui che il Padre ha mandato come immagine del suo amore e che la Madre ci affida come frutto del suo grembo. Spesso Maria è ritratta nella sua fisionomia femminile piena di grazia, e quindi di una affascinante bellezza, ma anche di quella riservatezza che la fa essere tutta rivolta a Dio: noi abbiamo così l’Immacolata, quando dobbiamo considerare che, ricolma della grazia divina, in lei non appare ombra di peccato; ma abbiamo anche la Donna gloriosa, che salendo a Dio e lasciandosi assorbire dal mondo celeste, risulta sempre più nella luce dell’empireo. Poi si aggiungono altre immagini che colgono un aspetto della sua presenza e della sua azione in favore del popolo cristiano. Fra tutte sono più frequenti le immagini che la mostrano con Gesù an-cora Bambino, fornendo così ciò che maggiormente la qualifica e cioè la sua maternità, quella che noi riconosciamo in modo particolare quando il bambino ha bisogno dell’assistenza della mamma; essa, in genere, tiene in braccio o tiene per mano il suo piccolo, o lo sorveglia con lo sguardo attento e premuroso. Come ogni donna che vive la maternità, anche lei rimane per sempre la madre di Cristo e, per la nostra conformazione a Lui, è pure madre nostra. E così la si può vedere anche in altri momenti della vita di Gesù, come la vediamo spesso affacciarsi a questo mondo, che ella visita spesso con le sue apparizioni. Ma come in queste noi possiamo riconoscerla nel suo privilegiare i piccoli, che sceglie come i suoi interlocutori, non unici, ma certamente più frequenti, così noi la immaginiamo “mamma di Gesù”, soprattutto quando ce l’ha vicino a sé nei momenti della sua infanzia, anche senza pensarla nei giorni iniziali della sua esistenza terrena dentro il rifugio di fortuna trovato a Betlemme. (Per continuare a leggere cliccare QUI